
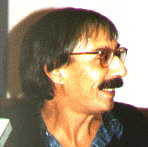 Antonio Zavaglia, Milano I
Antonio Zavaglia, Milano I
"FELICE ETA FU QUELLA, PRIMA DEI GIORNIDEGLI ARCHITETTI, PRIMA DEI GIORNI DEICONSTRUTTORI" Seneca (4.a.C - 65 d.C.)
Questo passo, estrapolato da una lettera a Lucilio di Lucio Anneo Seneca, in verita rivolto ai filosofi, puo essere un pretesto provocatorio, in un connvegno internazionale di architetti, storici dell arte e di studiosi di altre discipline, per approfondire il tema e la definizione del concetto di architettura popolare, di quella architettura, cioe, senza architetti, che non e un puro coacervo di tipologie edilizie tradizionalmente sprezate o del tutto ignorate, bensi la testimonianza materiale di modi di vivere che hanno gran peso sociale e culturale per chi li intenda a fondo, e ben poco invece se si parla di progresso.
In questo settore di studi e stata usata la terminologia piu varia: dallo spontaneo al contadino al rurale, dal vernacolare al rustico, dal minore al popolare. E Quest ultimo termine che maggiormente garantisce, e racchiude almeno teoricamente e allo stato attuale de dibattito, l ampiezza del ventaglio di orizzonti metodologici che a noi interessa.
Il concetto di architettura popolar si rifa infatti non tanto, o non solo, alla solida e sperimentata tradizione di studi di matrice geografica, ma a quella, piu recente e promettente nella sua impostazione metodologica generale, degli studi sul folklore, che ai contributi di matrice geografica affiancano quelli delle discipline storiche, archeologiche, antropologiche, storico-urbanistiche e architettoniche.
Mi sembra infatti, in larga approssimazione, e naturalmente nel senso specificamente disciplinare della storia dell architettura, che l architettura popolare debba essere considerata come un ambito d interessi e testimonianze integralmente accostabile agli altri settori della cultura demologica e folklorica, quali ad esempio la poesia popolare, la musica popolare, l arte popolare, la religione popolare, etc.
Questo approccio ricerca, innanzi tutto, le tracce e gli specifici apporti culturali di popoli e comunita (o meglio di una varieta di raggruppamenti umani reciprocamente intereeconnessi e comunque storicamente identificabili), piuttosto che continuare a vedere il fenomeno come risultato di un ambiente geografico o di un condziomento che procede a senso unico dalle aree urbanizzate verso le zone dove piu a lungo si e mantenuta la struttura territoriale delle comunita contadine.
Oggi piu che mai e infatti di prioritaria importanza tentare di restituire alla cultura popolare quella sua specifica identita che in altri settori le viene riconosciuta, ma che nel campo dell architettura e della organizzazione del territorio le viene, di fatto, ancora negata.
Lo stesso problema della casa contadina - delle sue forme, della sua storia, dei suoi significati - e stato, per cosi dire, ritagliato da un contesto culturale piu ampio, fino a integrarlo in una dimensione marginale e tuttavia sempre schematizzata in una rigida impalcatura tipologica.
Solo di recente si e presa in considerazione la struttura urbanistica dei centri con la stessa serieta dedicata alla casa rurale isolata, ma e ancora di la da venire uno studio realmente incentrato sull insediamento nel suo complesso inteso come prodotto culturale integralmente addebitabile alla storia della comunita che vi risiede, e non soltanto a processi piu o meno passivi di adattamento alle necessita ambientali o ai modelli esterni dominanti.
Possiamo definire l architettura poopolare come l insieme delle manifestazioni - riferibili a gruppi e comunita organizzate (prevalentemente rurali e artigiane) svolgenti attivita produttive in condizione di relativa autonomia culturale nei confronti delle societa urbane e degli organi dello Stato - inerenti alla costruzione, alla trasformazione e all uso dello spazio abitato, alla interpretazione complessiva del mondo fisico locale e del paesaggio, allo sfruttamento del territorio e alla sua riappropriazione rituale.
L architettura popolare puo quindi esseere considerata espressione della concreta necessita, da parte di societa spesso in difficili situazioni di emarginazione e subalternita, di attingere al proprio specifico patrimonio di credenze, di risorse materiali e di capacita technologiche nelle fasi determinanti del processo di continuo adattamento alle propri esigenze dell ambiente identificato come propria residenza storica e proprio ambito vitale.
In quanto prodotto dela comunita locale, l architettura popolare va posta, in primo luogo, in relazione con il "popolo" che l ha prodotto, tenendo conto delle stratificazioni temporali, dei condizionamenti fisici e geografici, degli scambi e degli scontri con le culture urbane e statutali, e analizzandone i caratteri, le componenti, le sia pur minime varianti sulla base dei dati storici e dell indagine demo-antropologica.
L isolamento dell argomente inerente la "casa contadina" dal suo contesto naturale . che e quello della comunita territoriale cui apartiene - e un fenomeno che appare riduttivo rispetto a interpretazioni piu complesse e, in prima istanza, piu generali, ma che hanno potuto indicare la via, in altri settori di studio, a piu fertili approfondimenti.
Basti pensare alla lunga tradizione di studi antropologici, che pure dell architetura ci hanno lasciato poche e frammentarie ricerche, per recuperare, in tutto il suo spessore, il problema della cultura delle comunita agricole locali e del loro rapporto con l insediamento, la casa, il territorio e il paesaggio. Cio vale in particolae per gli studi sulla festa, i ritti, le processioni, che pangono in risalto la forza e l originalita di tradizioni antichissime, differenziate da luogo a luoogo, create e tenute in vita con un opera continua e originale delle comunita locali che vi risiedono.
Un discorso esattamente parallelo si potrebbe, anzi si dovrebbe tentare per la struttura urbanistica dai centri contadini: indipendentemente da matrici e influenze cittadine o aristocratiche, da riconoscere e valutare caso per caso nella loro incidenza reale.
Si tratta, quindi, di imparare a conoscere e ad amare le tradizioni architettoniche e urbanistiche locali, di riannodare i fili dele multiformi attivita produttive di un mondo in continua trasformazione, dove, accanto alla modernita, coesistono caratteristiche specifiche e tratti culturali di antica origine e di vastissima diffusione.
Cio che e avvenuto, viceversa, in questo settore di studi, e stato fortemente condizionato e orientato dalla prospettiva geoantropica e, in misura minore, da quella puramente architettonico-cunstruttiva.
E evidente che cio e accaduto anche e soprattutto per una piu che giustificata esigenza di competenza tecnica che, per quanto si riferisce al territorio, va riconosciuta alla scienza goegrafica e, per quanto riguarda le tecniche, le forme, i materiali e caratteri distributivi della casa, e affidata alla scienza geografica e, per quanto riguarda le techniche, le forme, i materiali e caratteri distributivi della casa, e affidata alla settoriale competenza degli architetti.
Sono cosi rimasti quasi insondati, tranne qualche esperienza recente molto positiva, proprio quelle aree di ricerca storica, antropologica e urbanistica che, in una prospettiva di globalita, avrebbero potuto favorire il concretizzarsi di metodi di indagine articolati e complessi, all altezza di quelli che sono maturati, nel frattempo, nel campo degli studi della produzione architettonica monumentale oppure delle feste popolari.
Ma un altro elemento ha condizionato gli studi di geografi e architetti: l immediata connessione con una realta territoriale in rapida trasformazione che, impedendo un sufficiente distacco storico - critico nei confronti della cultura architettonica e urbanistica locale e, se vogliamo, autoctona, ha finito per riunire in un unico settore disciplinare le testimonianze di modi di costruie che risalgono alla protostoria e gli sviluppi contemporanei dell edilizia rurale.
E evidente che la cultura popolare architettonica puo sopravvivere naturalmente subendo continue trasformazioni, soltanto se permangono certe condizioni minime, quali possono essere una relativa autonomia gestionale, una relativa autarchia economica, una relativa refrattarieta culturale.
Tutte queste condizioni si sono verificate per la quasi totalita del mondo contadino negli ultimi secoli, e sono state solo recentemente messe in crisi dalla rivoluzione industriale per le aree piu precariamente coinvolte, dal secondo dopoguerra per quelle piu marginali.
Se ancora nell 800 per la quasi totalita delle comunita contadine delle aree collinari e montane si puo riscontrare il perdurare di una caratteristica attivita architettonica, locale, oggi si puo dire essa sia giunta al definitivo collasso.
L architettura e, infatti, tra i settori della produzione popolare quella piu sensibile ai mutamenti strutturali (economici e politici): la continuita di una tradizione implica la continuita della permanenza di una determinata comunita in una condizione di semisolamento che, ormai, appare ovonque superato.
Inoltre, se l introduz9ione di nuove tecniche e di nuovi materiali puo essere agevolmente assorbita nel quadro di attivita costruttive locali, essa appare puramente e semplicmente distruttiva se queste techniche e questi materiali rendono inutili a tutti gli effetti le attivita locali legate al architettura, vengono introdotte gia organizzate dall esterno.
Cade in tal modu quel nesso di necessita che ha legato per secoli (o per millenni) una determinata comunita a un determinato territorio di insediamento, un tempo anche sede esclusiva di approvigionamento dei materiali edilizi.
Spopolamento, emigrazione, turismo non cosciente hanno poi contribuito a dissolvere e snaturare embienti, paesaggi, insediameniti e case isolate.
Il patrimonio che ancora rimane da studiare - e possibilmente da tutelare e da valorizzare - e, comunque straordinariamente vasto; ma le distruzioni ne minacciano seriamente la stessa sopravvivenza.
Non e in gioco l esistenza giuridica e amministrativa delle comunita locali, ma il loro genius loci, che e la stessa loro vita e la loro identita culturale.


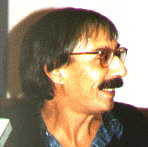 Antonio Zavaglia, Milano I
Antonio Zavaglia, Milano I