
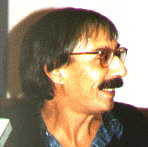 arch Antonio Zavaglia, I
arch Antonio Zavaglia, I
UNA POSSIBILE SALVAGUARDIA DELL ARCHITETTUURARURALE
Sono stati ampiamente studiati e sono pertanto conosciuti gli aspetti socio-economici e urbanistici relativi al degrado dell'edilizia rurale in Italia e in Lombardia.
Vorrei cercare di delineare un possibile percorso capace di attivare atteggiamenti e modalità d'uso che attenuino in qualche modo l'evoluzione prevedibile del fenomeno.
La strada, l'unica possibile - se si eccettuino le forme della museificazione, culturalmente inaccettabile e comunque proponibile per ambiti molto ristretti e particolari - è quella dell'intreccio tra bene culturale, tutela ambientale e nuovi bisogni turistici.
A partire dagli anni '50 la crescita rapida dei flussi turistici ha contribuito a creare seri problemi alla corretta conservazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale. Di fronte alla rilevanza del problema la Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ha deciso di istituire già nel 1977 un Gruppo di lavoro su "Ambiente e Turismo", e successivamente di pubblicare nel 1980 un rapporto avente per titolo "L'impatto del turismo sull'ambiente". Le raccomandazioni contenute in quel rapporto indicavano ai paesi membri una serie di misure nel campo dell'informazione, dell'istruzione, della politica economica, degli strumenti finanziari, e degli strumenti di gestione e pianificazione del territorio, al fine di minimizzare gli effetti negativi sull'ambiente.
Sono passati più di dieci anni ma assai poche delle raccomandazioni dell'OECD sono state recepite. D'altro canto il numero dei turisti è cresciuto assai più di quanto era possibile prevedere, e quindi sempre più preoccupante è l'impatto che le attività turistiche hanno sui beni naturali e culturali. Le previsioni per i prossimi decenni indicano un ulteriore massiccio aumento dei flussi turistici a fronte di condizioni ambientali già ampiamente compromesse.
In realtà molti degli effetti negativi attribuiti al turismo sono stati accentuati dai processi di concentrazione dell'offerta.
Anche le organizzazioni e le associazioni per la protezione della natura e dei beni culturali si sono già poste da più di venti anni la necessità di individuare forme di turismo appropriate alla fragilità di specifici ambienti costituenti il nostro patrimonio culturale e naturale. In particolare lo United Nations Environment Programme (UNEP) ha evidenziato già negli anni '70 il degrado dell'ambiente naturale, del paesaggio e delle componenti socio-culturali delle regioni mediterranee a causa di una crescita rapida e disordinata dell'industria turistica. Nel 1974 veniva calcolata la presenza di quasi tre turisti per metro lineare di costa nei paesi del Mediterraneo settentrionale, e si prevedeva che si sarebbe superato il livello di cinque turisti per metro di costa già dall'anno 1990.
L'UNEP proponeva nuovi modelli per lo sviluppo del turismo basati su una corretta politica regionale, sull'estensione alle zone interne del turismo costiero, sull'ampliamento della stagione delle vacanze, sull'utilizzazione delle infrastrutture abitative esistenti, su rigide norme anti-inquinamento, sulla formazione degli operatori e l'informazione degli utenti, ed infine sulla definizione di una serie di regole, una sorta di codice di condotta per il turismo, a cui avrebbe dovuto far riferimento sia la domanda che l'offerta turistica.
Il termine "turismo verde" è stato per la prima volta usato nelle aree rurali, dove per la conservazione della quiete e dell'amenità dei luoghi era necessario e opportuno evitare gli eccessi del turismo di massa. In Francia già negli anni '70 il Governo si era posto il problema di studiare gli elementi frenanti del turismo verde in area rurale e di individuare gli strumenti normativi, finanziari e promozionali per rilanciarlo. Nel corso degli anni '80 alcuni studiosi di lingua tedesca, soprattutto facendo riferimento al turismo montano, hanno cominciato ad usare il termine sanfter Tourismus in contrapposizione al termine hard tourismus, con il quale si èvoluto indicare un turismo di massa basato sullo sci da discesa, e quindi sulla realizzazione di piste e di impianti di risalita che incidevano profondamente il paesaggio. Tale concetto è poi entrato nella letteratura internazionale attraverso la versione francese di tourisme doux utilizzata nei documenti prodotti dalla Commission Internationale pour la Protection des Regions Alpines (CIPRA). In Italia, alla traduzione letterale di "turismo dolce", poco utilizzata, è stato preferito il termine "turismo alternativo".
Più di recente si è cominciato ad usare il termine Sustainable Tourism per la definizione di criteri e principi per lo sviluppo di un turismo rispettoso dell'ambiente.
Tutto questo per evidenziare come nella nostra società si è ormai diffuso un modello culturale in cui lo sviluppo economico non deve prescindere dalla tutela, salvaguardia e recupero dei beni naturali e culturali, e quindi dal miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane e rurali. La grande attenzione per le problematiche ambientali si è imposta a livello europeo durante gli anni ottanta, quando l'opinione pubblica si ècominciata ad interessare in modo massiccio a quelle tematiche che negli anni e nei decenni precedenti erano state oggetto di attenzione esclusivamente da parte di pochi intellettuali e di gruppi di cittadini attivi nelle associazioni ambientaliste. Questo fenomeno stimolato dalla diffusione di documenti relativi ai processi di sviluppo economico e delle conseguenze sull'ambiente è però principalmente avvenuto sulla base di un comune senso di rifiuto di un modello di vita che fosse legato al decadimento dei quartieri storici, allo squallore delle aree residenziali, all'aumento indiscriminato dell'inquinamento acustico ecc.
Tutto ciò si andava ad aggiungere alle preoccupazioni quotidiane per la salute, propria e dei propri figli, esposta ai rischi degli additivi chimici nelle sostanze alimentari, dei residui di fitofarmaci nella frutta e nella verdura, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua.
Questa premessa, con gli scenari delineati, ci aiuta a porci la domanda se i "nuovi bisogni" possono intrecciarsi con il nostro obiettivo prioritario, che è quello della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, mediante l'utilizzazione turistica.
Io penso di si, a patto che il recupero di queste strutture non si limiti ad una operazione a carattere edilizio-architettonico.
La piena valorizzazione degli edifici rurali esige infatti che l'ambiente circostante e i soggetti operatori determinino un'offerta turistica profondamente caratterizzata in chiave ecologica, culturale ed agricola, con conseguenti riflessi enogastronomici. Da qui il significato dell'agriturismo come attività connessa e complementare dell'agricoltura, e di tutte quelle forme di turismo rurale che escludono le nuove costruzioni, privilegiando uno stretto collegamento con la realtà ambientale, sociale ed economica circostante.
Le prospettive di sviluppo dell'agriturismo in Italia e in Lombardia, sono molto positive in quanto si registra una costante crescita della domanda determinata sia dal congestionamento delle tradizionali sedi turistiche, sia da un ben preciso orientamento verso vacanze a contatto con la natura, con una alimentazione tipica e genuina, ospiti di dimore con caratteristiche particolari.
L'Italia, sotto questo ultimo aspetto, offre una straordinaria varietà di tipologie edilizie rurali, tutte con radici molto antiche, capaci di determinare da sole il volto del paesaggio e dell'ambiente rurale. Basti pensare ai masi altoatesini (dove si concentra circa il 30% dell'offerta agrituristica nazionale), alle cascine lombarde e padane, alle ville e ai casolari toscani e umbri, ai trulli pugliesi, alle masserie (spesso fortificate) diffuse in tutto il Mezzogiorno.
Stanti le prospettive favorevoli della domanda di agriturismo si pone il problema di come consolidare e sviluppare l'offerta, attraverso un consistente restauro e utilizzo del patrimonio edilizio rurale. Problema notevole, considerando che gli interventi sugli edifici rurali richiedono investimenti finanziari molto rilevanti il cui ritorno in termini economici è poi dilazionato nel tempo.
Tenuto conto delle dimensioni complessive e delle caratteristiche del patrimonio edilizio rurale lombardo e italiano suscettibile di recupero (probabilmente il più notevole a livello non solo europeo ma addirittura mondiale) è necessaria una politica molto incisiva di sostegno all'iniziativa dei singoli agricoltori. In particolare si dimostra insufficiente l'attuale erogazione delle Regioni (anche della Lombardia), di contributi a fondo perduto di cui beneficia un numero molto limitato di imprenditori, mentre è opportuno prevedere agevolazioni fiscali che pongano il maggior numero di operatori nella condizione di poter intraprendere l'attività turistica. Condizione essenziale per ottenere tali agevolazioni dovrebbe comunque essere - come la legge italiana sull'agriturismo già prevede - il recupero degli edifici nel pieno rispetto delle originali caratteristiche architettoniche.
Esiste d'altra parte più di una solida motivazione ad operare in questo senso. Prima di tutto perchè la salvaguardia del paesaggio agrario e la conservazione dell'integrità urbanistica dello spazio rurale sono presupposti essenziali per la valorizzazione turistica complessiva del territorio; diversamente da quanto si sente spesso affermare, l'agriturismo non solo non deve rappresentare un concorrente del turismo "tradizionale" ma può dare un contributo essenziale alla integrazione e alla diversificazione delle attrattive turistiche (paesaggio, prodotti agroalimentari tipici, artigianato, ecc.).
E' importante, poi, la rilevanza ambientale della presenza sul territorio di agricoltori sensibili alle esigenze turistiche, al punto che la cura di siepi, sentieri, alberi sparsi, coltivazioni a basso impatto ambientale, potrebbe rappresentare in prospettiva un vero e proprio servizio svolto a beneficio della collettività. Infine va sottolineato il valore storico e culturale che il patrimonio edilizio rurale rappresenta. Un valore che non si può limitare alla conservazione di singoli edifici di particolare pregio, dovendo testimoniare piuttosto dei veri e propri sistemi insediativi, impareggiabili per spontanea armonia con l'ambiente.
E' dunque necessario che dalla armonizzazione e migliore finalizzazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, scaturiscono le condizioni per un saggio governo di queste preziose risorse da parte del mondo rurale, e degli agricoltori in particolare. In tal modo, oltre a creare le condizioni per un allargamento delle aree di sviluppo turistico, si offrirà a molta parte del mondo rurale l'ormai indifferibile opportunià di nuove iniziative economiche.
L'ostacolo principale al recupero del patrimonio edilizio rurale a fini agrituristici è rappresentato dall'alto costo degli interventi di restauro. Una recente indagine condotta dall'Agriturist in Toscana indica che l'allestimento di un posto letto (recupero della struttura, arredi, impianti, ecc.) costa mediamente dai 15 ai 30 milioni. Ciò significa che per avviare un'attività ricettiva di modeste dimensioni (10 - 12 posti letto) utilizzando un edificio disponibile in azienda, si devono investire circa 200 - 250 milioni.
E' evidente pertanto la difficoltà non solo di reperimento, da parte dell'agricoltore di una somma così rilevante, ma anche di raggiungere la convenienza economica di tale investimento.
Ciò emerge chiaramente osservando la mappa dello sviluppo agrituristico italiano: il maggior numero di aziende agricole che offre ospitalità si trova in zone (Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria) dove già preesisteva un consistente movimento agrituristico rurale, legato o al pregio naturalistico dei luoghi (Trentino Alto Adige) o alla presenza di molteplici richiami culturali in borghi e piccoli centri, nonchè di un paesaggio particolarmente ameno (Toscana e Umbria).
E' preoccupante constatare invece che in territori meno conosciuti sotto il profilo turistico eppure interessanti dal punto di vista ambientale e paesaggistico - è il caso della Lombardia - l'agriturismo fatichi a crescere; e ciò proprio perchè mancano flussi turistici tali da giustificare l'investimento sul recupero edilizio. Sono soprattutto queste le realtà su cui occorre incidere, orientando gli incentivi per il recupero edilizio, realizzando infrastrutture e servizi essenziali, organizzando campagne promozionali, che riducano le condizioni di obiettivo svantaggio di queste zone.
La legge 730/85, che definisce e disciplina in Italia l'agriturismo, stabilisce norme specifiche sul recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, impedendo la realizzazione di nuove costruzioni in campagna. Questo importante principio tiene conto della particolare fragilità dell'ambiente rurale, la cui integrità e, di conseguenza, il valore turistico, è legata indissolubilmente all'agricoltura e ai "segni" che l'agricoltura ha creato e modellato sul territorio (edifici, coltivazioni, siepi, filari, alberi sparsi, ecc). Il paesaggio agrario rappresenta appunto il complesso di questi segni, nel quale gli edifici rappresentano componente decisiva anche se da considerare in rapporto indissolubile con il contesto circostante. Il proliferare di nuovi edifici in campagna, la cui finalizzazione sarebbe essenzialmente turistica (seconde case o strutture ricettive gestite imprenditorialmente), rappresenta una pericolosa forma di autodistruzione.
Contro questo rischio è necessario che ogni altra normativa che riguarda l'edificazione in campagna sia allineata alla assoluta priorità del recupero degli edifici esistenti. Diversamente ciò che con l'agriturismo ci si prefigge di preservare viene poi vanificato da iniziative prese in altri settori.
Nell'ampio ed eterogeneo "contenitore" del turismo rurale, èdunque essenziale che anche gli albeghi, case per vacanze, villaggi albergo, residence, campeggi, siano vincolati al rigoroso recupero degli edifici esistenti. Anzi tale recupero dovrebbe essere incoraggiato per creare motivazioni imprenditoriali anche in presenza del vincolo a non costruire nuove strutture.
Gli esempi dell'Alto Adige, della Toscana, dell'Umbria, dove norme urbanistiche rigorose e tempestive hanno permesso di fare del paesaggio un protagonista importante dell'economia, devono farci riflettere.
Antonio Zavaglia: "Edifici rurali: una risorsa culturale, ambientale ed economica da salvaguardare e valorizzare".


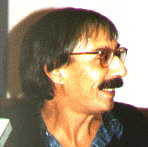 arch Antonio Zavaglia, I
arch Antonio Zavaglia, I